E poi c'è una scrittura che non si è mai
privata di una dimensione onirica, si rappresenta pregevole e di
grandissimo livello e accompagna l'elaborazione filosofica in maniera
armoniosa ed equilibrata. Di tutto questo dà una visione d'insieme il
volume di Heimo Schwilk Ernst Jünger. Una vita lunga un secolo (Effatà,
pagg. 720, euro 22) che usufruisce di documenti di prima mano (l'autore
ha frequentato Jünger e ne ha scritto molto) e ci dona un'inusuale
corposità aneddotica.
Immaginatevi tutti i flashback. Un giovane che, diciottenne, scappa
di casa e si arruola nella Legione straniera. Va in Francia e in
Algeria. Ma ben presto si accorge che i ludi africani non hanno nulla di
romantico o di esotico e quando, per le pressioni del padre presso il
ministero degli Esteri tedesco, viene richiamato in patria, si sente
quasi sollevato. Cambia molti istituti scolastici (e qui sembra di
rivivere le vicende italiane di Papini e Prezzolini) con l'aggravante di
un padre complice: «Nei colloqui a tavola all'ora di pranzo - scrive
Schwilk - schernisce davanti ai figli i metodi d'insegnamento di allora
\. Sicché la vera e propria formazione culturale e personale si svolge
del tutto al di fuori della scuola \».
All'inizio Ernst non ama nemmeno la divisa militare, eppure va da
volontario alla Prima guerra mondiale. Ferito quattordici volte, viene
insignito della Croce di ferro di prima classe e poi della più alta
onorificenza prussiana, l'ordine Pour le Mérite. Scelte apparentemente
contraddittorie, ma il motivo è ravvisabile nell'anarchismo che, nel
tempo delle mobilitazioni delle masse, del disvelamento di tutte le
inquietudini della modernità e del peso sempre più ossessivo del
disumano, acquista in lui un rinnovato valore di libertà: «Ernst
apprezza e ama l'ordine e non gli manca il gusto di infrangerlo. \ I
problemi disciplinari e le insufficienti prestazioni scolastiche ne sono
la conseguenza».
Resta per qualche tempo nell'esercito, ma ormai la fama gli consente
di vivere con la scrittura. Quando Nelle tempeste d'acciaio viene messo
sul mercato, nell'ottobre del '20, diventa subito una rarità per
collezionisti. Inizia a collaborare con riviste in cui confluiscono
radicali di ogni risma. Sin da questa fase è impossibile inserirlo in un
orientamento filosofico o politico, perché egli non affronta con
altezzosità accademica le varie tematiche, ma le dipana anche attraverso
il vissuto quotidiano e i romanzi letterari. Si ha la sensazione che,
come ricorda Schwilk, dovunque fugga «rimane un originale e un
solitario. La problematicità della sua esistenza è anche la causa prima
di un coraggio temerario, che non conosce ansie né paure di fronte al
pericolo della morte, e anzi sembra andarne in cerca. Come se la morte
fosse l'unica possibilità di vincere il senso di colpa per poi tornare
all'origine materna della vita».
Utilizza infatti lo strumento
letterario per svelare l'altra faccia della civilizzazione che è la
barbarie; quell'angoscia heideggeriana che lega la libertà alla
questione della tecnica. Si convince che la ricerca ossessiva della
perfezione e della sicurezza cui aspiriamo in ogni ambito della vita
individuale e sociale svela un incremento del livello di paura rispetto
al passato. Ne Al muro del tempo scriverà che le democrazie si
trasformano e ci trasformano in modo occulto e questa lettura si evince
anche dalla comprensione per certi versi profetica della crisi degli
stati nazionali i quali, nel momento in cui cedono quote di potenza alla
tecnica e all'idea di sicurezza e di prevenzione, capitolano al grande
fratello planetario. I romanzi Eumeswil, Le api di vetro, Il problema di
Aladino, Heliopolis ci parlano di questo. Jünger ha infatti compreso
prima di tutti che la mobilitazione è passata dai campi di battaglia
alle officine, e ben presto passerà a ogni ambito di lavoro.
Anche per questo non aderì mai al nazismo nonostante i ponti d'oro
fattigli da Goebbels. Tuttavia non si fece mancare neanche un'indiretta
responsabilità nel più famoso attentato a Hitler. Era infatti a
conoscenza dell'operazione Valchiria, tanto che in quelle ore
drammatiche iniziò a figurare il suo nome tra i congiurati. Qualcuno
disse che Hitler avesse ordinato di non toccarlo, ma intanto i gerarchi
nazisti mandarono suo figlio Ernstel a morire a Carrara in prima linea.
Il coinvolgimento non fu mai provato, e tutta la seconda parte di una
vita ultracentenaria la trascorse a Wilflingen, nella foresteria del
castello dei von Stauffenberg, e la cronaca di quei drammatici giorni
fatta da Schwilk ce lo mostra timoroso per se stesso e per la sua
famiglia e attento a far sparire carte di vario tipo.
Dagli anni Sessanta continua il suo percorso di ricerca esplorando
strade parallele. Sperimenta le droghe, in particolare l'LSD, e poi
dirige insieme a Mircea Eliade la rivista Antaios che si occupa di
storia delle religioni. Cerca insomma il bosco in ogni modo: «Trovarsi
soli di fronte alla propria finitezza è uno dei grandi incontri. Né dèi,
né animali, ne sono partecipi». Si confronta con Carl Schmitt e Martin
Heidegger non senza qualche chiosa puntuta a livello personale, ma
questi scambi restano tra i punti più alti della produzione
intellettuale del Novecento.
Intanto si è messo a studiare i
coleotteri. La scelta è chiara. È convinto che il nostro tempo
rappresenti una tappa di transizione fra due momenti della storia, come
accadde al tempo di Eraclito: «Egli si trovava tra il Mito e la Storia.
Noi invece ci troviamo in una fase ulteriore e transitoria dominata dal
titanismo. Dobbiamo esplorare le profondità, introdurci negli
interstizi». Quindi passa dallo stato mondiale alla caccia sottile. E
così Wilflingen diventa il suo mondo. Morì cinque anni dopo il
secondogenito Alexander che si era tolto la vita.
E poi c'è una scrittura che non si è mai
privata di una dimensione onirica, si rappresenta pregevole e di
grandissimo livello e accompagna l'elaborazione filosofica in maniera
armoniosa ed equilibrata. Di tutto questo dà una visione d'insieme il
volume di Heimo Schwilk Ernst Jünger. Una vita lunga un secolo (Effatà,
pagg. 720, euro 22) che usufruisce di documenti di prima mano (l'autore
ha frequentato Jünger e ne ha scritto molto) e ci dona un'inusuale
corposità aneddotica.
Immaginatevi tutti i flashback. Un giovane che, diciottenne, scappa
di casa e si arruola nella Legione straniera. Va in Francia e in
Algeria. Ma ben presto si accorge che i ludi africani non hanno nulla di
romantico o di esotico e quando, per le pressioni del padre presso il
ministero degli Esteri tedesco, viene richiamato in patria, si sente
quasi sollevato. Cambia molti istituti scolastici (e qui sembra di
rivivere le vicende italiane di Papini e Prezzolini) con l'aggravante di
un padre complice: «Nei colloqui a tavola all'ora di pranzo - scrive
Schwilk - schernisce davanti ai figli i metodi d'insegnamento di allora
\. Sicché la vera e propria formazione culturale e personale si svolge
del tutto al di fuori della scuola \».
All'inizio Ernst non ama nemmeno la divisa militare, eppure va da
volontario alla Prima guerra mondiale. Ferito quattordici volte, viene
insignito della Croce di ferro di prima classe e poi della più alta
onorificenza prussiana, l'ordine Pour le Mérite. Scelte apparentemente
contraddittorie, ma il motivo è ravvisabile nell'anarchismo che, nel
tempo delle mobilitazioni delle masse, del disvelamento di tutte le
inquietudini della modernità e del peso sempre più ossessivo del
disumano, acquista in lui un rinnovato valore di libertà: «Ernst
apprezza e ama l'ordine e non gli manca il gusto di infrangerlo. \ I
problemi disciplinari e le insufficienti prestazioni scolastiche ne sono
la conseguenza».
Resta per qualche tempo nell'esercito, ma ormai la fama gli consente
di vivere con la scrittura. Quando Nelle tempeste d'acciaio viene messo
sul mercato, nell'ottobre del '20, diventa subito una rarità per
collezionisti. Inizia a collaborare con riviste in cui confluiscono
radicali di ogni risma. Sin da questa fase è impossibile inserirlo in un
orientamento filosofico o politico, perché egli non affronta con
altezzosità accademica le varie tematiche, ma le dipana anche attraverso
il vissuto quotidiano e i romanzi letterari. Si ha la sensazione che,
come ricorda Schwilk, dovunque fugga «rimane un originale e un
solitario. La problematicità della sua esistenza è anche la causa prima
di un coraggio temerario, che non conosce ansie né paure di fronte al
pericolo della morte, e anzi sembra andarne in cerca. Come se la morte
fosse l'unica possibilità di vincere il senso di colpa per poi tornare
all'origine materna della vita».
Utilizza infatti lo strumento
letterario per svelare l'altra faccia della civilizzazione che è la
barbarie; quell'angoscia heideggeriana che lega la libertà alla
questione della tecnica. Si convince che la ricerca ossessiva della
perfezione e della sicurezza cui aspiriamo in ogni ambito della vita
individuale e sociale svela un incremento del livello di paura rispetto
al passato. Ne Al muro del tempo scriverà che le democrazie si
trasformano e ci trasformano in modo occulto e questa lettura si evince
anche dalla comprensione per certi versi profetica della crisi degli
stati nazionali i quali, nel momento in cui cedono quote di potenza alla
tecnica e all'idea di sicurezza e di prevenzione, capitolano al grande
fratello planetario. I romanzi Eumeswil, Le api di vetro, Il problema di
Aladino, Heliopolis ci parlano di questo. Jünger ha infatti compreso
prima di tutti che la mobilitazione è passata dai campi di battaglia
alle officine, e ben presto passerà a ogni ambito di lavoro.
Anche per questo non aderì mai al nazismo nonostante i ponti d'oro
fattigli da Goebbels. Tuttavia non si fece mancare neanche un'indiretta
responsabilità nel più famoso attentato a Hitler. Era infatti a
conoscenza dell'operazione Valchiria, tanto che in quelle ore
drammatiche iniziò a figurare il suo nome tra i congiurati. Qualcuno
disse che Hitler avesse ordinato di non toccarlo, ma intanto i gerarchi
nazisti mandarono suo figlio Ernstel a morire a Carrara in prima linea.
Il coinvolgimento non fu mai provato, e tutta la seconda parte di una
vita ultracentenaria la trascorse a Wilflingen, nella foresteria del
castello dei von Stauffenberg, e la cronaca di quei drammatici giorni
fatta da Schwilk ce lo mostra timoroso per se stesso e per la sua
famiglia e attento a far sparire carte di vario tipo.
Dagli anni Sessanta continua il suo percorso di ricerca esplorando
strade parallele. Sperimenta le droghe, in particolare l'LSD, e poi
dirige insieme a Mircea Eliade la rivista Antaios che si occupa di
storia delle religioni. Cerca insomma il bosco in ogni modo: «Trovarsi
soli di fronte alla propria finitezza è uno dei grandi incontri. Né dèi,
né animali, ne sono partecipi». Si confronta con Carl Schmitt e Martin
Heidegger non senza qualche chiosa puntuta a livello personale, ma
questi scambi restano tra i punti più alti della produzione
intellettuale del Novecento.
Intanto si è messo a studiare i
coleotteri. La scelta è chiara. È convinto che il nostro tempo
rappresenti una tappa di transizione fra due momenti della storia, come
accadde al tempo di Eraclito: «Egli si trovava tra il Mito e la Storia.
Noi invece ci troviamo in una fase ulteriore e transitoria dominata dal
titanismo. Dobbiamo esplorare le profondità, introdurci negli
interstizi». Quindi passa dallo stato mondiale alla caccia sottile. E
così Wilflingen diventa il suo mondo. Morì cinque anni dopo il
secondogenito Alexander che si era tolto la vita.
(di Luigi Iannone)

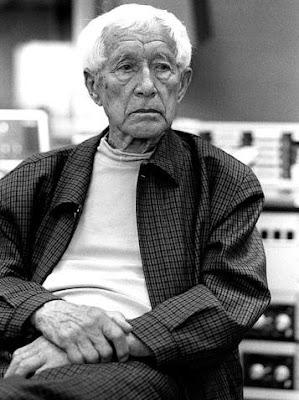
Nessun commento:
Posta un commento